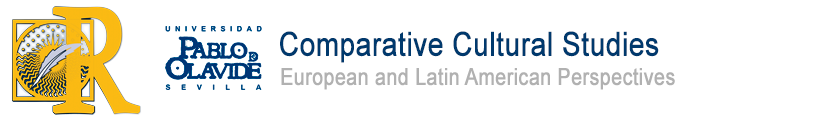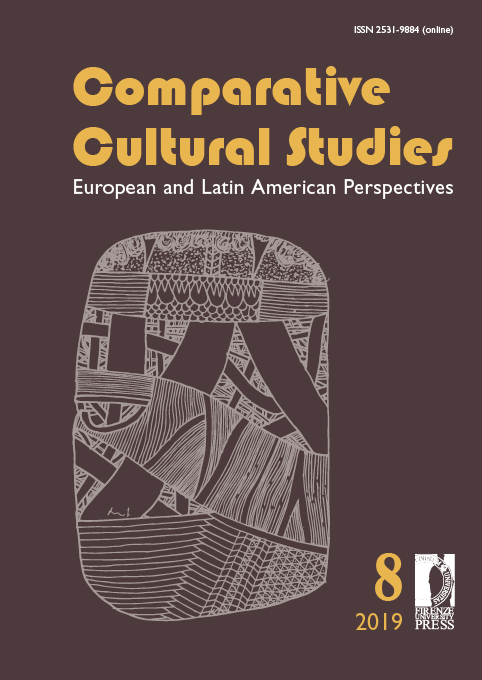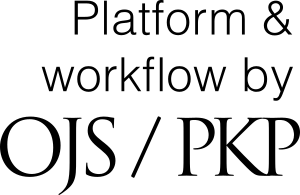Processi di inclusione e di esclusione nelle scuole multiculturali. Un’indagine preliminare nel territorio toscano
DOI:
https://doi.org/10.13128/ccselap-10867Parole chiave:
hate speech, multiculturalismo, relazioni interetniche, comunità scolastica inclusivaAbstract
Una delle sfide comuni a tutte le società multiculturali è quella di trova-re nuove pratiche per trasformare la diversità in un’opportunità di apprendimento, di inclusione e parallelamente limitare la nascita di processi di radicalizzazione violenta. Da questa prospettiva, tutti i contesti di vita - tra cui quello scolastico - richiedono in maniera sempre più attenta ai diversi professionisti di acquisire e sviluppare competen-ze multiculturali specifiche per gestire tale complessità; l’incontro interculturale infatti non sempre si evolve in relazioni sociali positive e la definizione di caratteristiche nega-tive attribuite all’altro percepito come diverso può talvolta legittimare l’utilizzo di un linguaggio dell’odio, l’ostilità nella relazione e l’uso della violenza. Per le scuole italiane che operano in contesti multiculturali e a forte complessità sociale, tutto questo si tra-duce in una duplice sfida: per le istituzioni medesime, significa promuovere al proprio interno la dimensione dell’apertura e del riconoscimento reciproco, così come al pro-prio esterno rapporti di rete stabili e fecondi con il territorio di riferimento e le altre istituzioni presenti; per gli insegnanti, favorire i processi di apprendimento degli allievi che dispongono di un patrimonio culturale differente e gestire eventuali episodi di con-flitto interetnico che possono manifestarsi nelle classi. Il presente lavoro intende esplo-rare episodi di discriminazione rilevati all’interno di alcune scuole toscane ad elevata complessità multiculturale, con l’obiettivo di analizzare le pratiche che gli insegnanti mettono in campo per farvi fronte e promuovere comunità educative inclusive. Come vedremo, l’analisi qualitativa dei materiali testuali prodotti dai docenti coinvolti per-mette di rilevare due principali pattern di significato: le relazioni interetniche a scuola da un lato; le competenze del docente multiculturale dall’altro. La riflessione critica sui temi che riguardano la scuola multiculturale, inoltre, può favorire processi di appren-dimento basati sull’esperienza permettendo di definire modalità e strategie efficaci per migliorare i processi di inclusione, sia dentro che fuori l’aula.
Downloads
Riferimenti bibliografici
Benesch, S. (2014). Defining and diminishing hate speech. Freedom from hate: State of the world’s minorities and indigenous peoples, 18-25.
Braun, V., & Clarke, V. (2014). What can “thematic analysis” offer health and wellbeing researchers? International journal of qualitative studies on health and well-being, 9.
Carnagey, N. L., Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2007). The effect of video game violen-ce on physiological desensitization to real-life violence. Journal of Experimental Social Psychology, 43, 489–496. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2006.05.003
Chakir, K. (2016), Dal discorso dell’odio al discorso al discorso del rispetto nelle scuole d’infanzia. Encyclopaideia XX (46), 120-142, 2016, ISSN 1825-8670Chong, D. (2006). Free speech and multiculturalism in and out of the academy. Political Psychology, 27(1), 29-54.
Cottrell, C. A., & Neuberg, S. L. (2005). Different emotional reactions to different groups: a sociofunctional threat-based approach to” prejudice”. Journal of personality and social psychology, 88(5), 770.
Craft, M. (2017). Teaching in a Multicultural Society: the task for teacher education. Routledge.
Davidson, T., Warmsley, D., Macy, M., & Weber, I. (2017). Automated hate speech detection and the problem of offensive language. In Eleventh International AAAI Conference on Web and Social Media.
Fabbri, L., & Romano, A. (2017). Metodi per l’apprendimento trasformativo. Casi, modelli, teorie. Roma: Carocci.
Fook, J., & Askeland, G. A. (2007). Challenges of critical reflection:‘Nothing ventured, nothing gained’. Social work education, 26(5), 520-533.
Gagliardone, I., Gal, D., Alves, T., & Martinez, G. (2015). Countering online hate speech. Unesco Publishing.
Greenberg, J., & Pyszczynski, T. (1985). The effect of an overheard ethnic slur on evalua-tions of the target: How to spread a social disease. Journal of Experimental Social Psy-chology, 21, 61–72. https://doi.org/10.1016/ 0022-1031(85)90006-X
Haslam, N., Rothschild, L., & Ernst, D. (2000). Essentialist beliefs about social categories. British Journal of Social Psychology, 39(1), 113-127.
Leets, L. (2001). Explaining perceptions of racist speech. Communication Research, 28, 676–706. https://doi.org/10.1177/009365001028005005
Miller, J.A. (1989), Ekstimnost. Problemi, 27(5), 33-46.
Orefice C. (2016). Fomentar la investigación, la formación y el desarrollo de programas sobre el campo de la diversidad cultural: el Proyecto Europeo GOVDIV. In: F. Gerva-si (coordinador). Diversidades. Perspectivas multidisciplinarias para el estudio de la interculturalidad y el desarrollo social, México: Ediciones Universidad Autónoma de Coahuila - DeLaurel, pp. 461-478.
Soral, W, Bilewicz, M., & Winiewski, M. (2018), Exposure to hate speech increases prejudice through desensitization. Aggressive Behavior. 44, 136–146.
Van Overwalle, F., & Jordens, K. (2002). An adaptive connectionist model of cognitive disso-nance. Personality and Social Psychology Review, 6(3), 204-231.
Verkuyten, M., & Martinovic, B. (2006). Understanding multicultural attitudes: The role of group status, identification, friendships, and justifying ideologies. International Journal of Intercultural Relations, 30(1), 1-18.
Downloads
Pubblicato
Come citare
Fascicolo
Sezione
Licenza
Copyright (c) 2019 Carlo Orefice, Marco Betti, Nicolina Bosco

TQuesto lavoro è fornito con la licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.
Questa licenza consente a terzi di condividere (copiare e ridistribuire il materiale in qualsiasi mezzo o formato) e adattare (remixare, trasformare e creare dal materiale per qualsiasi scopo, anche commerciale), a condizione che sia riconosciuta la paternità e la prima pubblicazione in questa rivista (La Rivista, DOI del lavoro), che sia fornito un link alla licenza e che sia indicato se sono state apportate modifiche al lavoro.